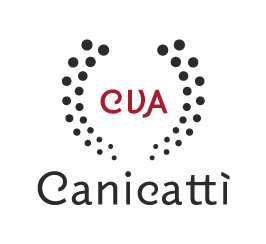Riprendo questo interessante articolo di un produttore dei colli piacentini, per confermare che in linea generale sono molto d’accordo con quanto affermato nel suo scritto.
Vorrei aggiungere a completamento, quanto mi ha confermato quello che, a mio avviso, è il piu’ grande e preparato enologo che ho incontrato in vita mia, il francese Patrick Vallette produttore di vini in Bordeaux e direttore della grande azienda cilena Vik. Sono stato in visita a questa grande azienda cilena che conta su 4.300 ha di terreni, praticamente tutta una vallata, ed ad oggi oltre 1.000 ha di vigneti, alcuni anni fa e ne ho scritto ampiamente un report qui : https://www.winetaste.it/ita/anteprima.php?id=6473
e per quanto mi ha raccontato e per l’altissimo livello qualitativo dei vini prodotti, ho capito che trovarsi di fronte un allievo del piu’ grande enologo di tutti i tempi il prof. Emile Peynaud non è cosa di tutti i giorni ( anche il nostro Giacomo Tachis, padre del vino Sassicaia è stato suo allievo ).

Mi confermava Patrick Vallette che i piu’ grandi vini a livello planetario si ottengono e sono ottenuti da blend, ovvero da un insieme di piu’ vini ottenuti da diverse tipologie. Le eccezioni che pure esistono ( leggasi Barolo, Brunello, Aglianico ecc. ) confermano la regola piu’ generale !
Buona lettura
RG
Un articolo di Stefano Pizzamiglio, titolare dell’azienda agricola La Tosa, sui motivi che storicamente hanno portato i vignaioli italiani, ma non solo, a sviluppare vini in uvaggio.


Ha più senso, qualitativamente parlando, produrre vini da mescolanze di vitigni (come veniva più frequentemente fatto in passato) o da vitigno unico? E’, questo, un argomento su cui si è dibattuto molto in questi ultimi anni nel mondo enologico. Spesso a vuoto, penso, perché non credo si possa stabilire una legge universale a proposito di ciò, ma valutare caso per caso, considerando soprattutto gli obiettivi che ci si pone di raggiungere producendo un vino. E’ nella tradizione di quasi tutte le zone produrre vini da un’insieme di uve, un po’ per il classico atteggiamento prudenziale tipico del mondo contadino, un po’ per il difficilmente contenibile pullulare di mutazioni e incroci spontanei formatisi e stratificatisi nel corso del tempo nei vigneti. Il termine uvaggio, come base compositiva di un vino, significava, una volta, non di un insieme 2-4 uve come concepiamo oggi, quando si parla di uvaggio, ma, spesso, di un esercito di svariati vitigni, a volte sconosciuti al loro stesso coltivatore. Questo insieme di tanti (anche 5-10 e più) vitigni si è andato col tempo sempre più assottigliando nel numero, setacciato dall’uomo che col tempo ha mantenuto in vita, ossia nei propri vigneti, solo i vitigni più interessanti.
Oggi, rispetto alle epoche in cui si sono formate e consolidate le tradizioni di certi uvaggi, le motivazioni che spingono un viticoltore a coltivare un vitigno piuttosto che un altro ci possono apparire diverse da quelle di un tempo. In realtà, credo che ‘molle’ come l’ambizione personale a fare sempre meglio, le mode, le considerazioni economiche anche più spinte, siano sempre esistite, ma che abbiano influito sulla produzione vinicola passata solo in modo meno appariscente rispetto ad oggi: o meglio, con una misura più diluita nel tempo, vista la infinitamente minore ricchezza e disponibilità di mezzi di comunicazione, rispetto all’epoca odierna.
Ho detto questo perché ritengo che, ove presente, occorra cercare il senso profondo di certe tradizioni; a volte, si tratta anche di cercarlo per la prima volta, perché non è detto che le motivazioni di certe usanze e scelte di fondo fossero, in passato, così consce. Allo stesso modo, occorre capire le motivazioni profonde in virtù delle quali si vuole radicalmente cambiare certe tradizioni, o semplicemente rifuggirne. A volte queste motivazioni sono proprio profonde, legate a una ricerca di nuovi orizzonti sensoriali-qualitativi, o a una riarmonizzazione del prodotto con la percezione collettiva di chi ne fruisce nel frattempo mutata; a volte sono più superficiali, legate a ragioni di comodità dal punto di vista pratico-economico o al frettoloso assecondamento di una moda sicuramente motivata ma non così profondamente.


Ho recentemente avuto modo di degustare alcune basi di cantina di un rosso taglio bordolese (Cabernet-Merlot; qua il Cabernet era Cabernet Sauvignon), scomposto nelle sue componenti: i vini provenienti dalle due uve, ancora non mescolati assieme, degustati alla cieca di fianco all’ipotetico taglio tra essi stessi. Balzava subito agli occhi, o meglio al naso e al palato, che la personalità dei due diversi vitigni, e i loro pregi ma anche i loro limiti, fossero ben evidenti nei campioni in cui essi recitavano un monologo, campioni di certo altamente emozionali, personali. Nel campione in cui si recitava un dialogo, ossia nel taglio, se l’appeal più direttamente emozionale del vino era appena un po’ più sottotono, l’appeal organolettico generale, in tutta la sua completezza, era esaltato: più morbidezza, più calore, più avvolgenza, più bevibilità rispetto ai due campioni provenienti da monovitigno. Particolare importante: la percentuale del Merlot, vino notoriamente più delicato, meno potente e invasivo del Cabernet Sauvignon, non superava, nel taglio, il 12%. Questa degustazione mi ha disvelato, d’un colpo e da immediatezza organolettica (non da riflessione culturale), il perché di una tradizione plurisecolare come quella dell’uvaggio bordolese nella sua terra d’origine, il Medoc. Quella scarna percentuale, nel taglio, del timido Merlot era stata sufficiente a rendere il vino forse, ripeto, meno diretto, meno emozionale, però sicuramente più equilibrato, più maturo, più ‘adulto’: e il bicchiere di quel vino in pochi minuti l’avevo vuotato, a differenza dei suoi due simili. Ho rivissuto d’un colpo, dunque, quella tradizione, che, partita secoli fa da un uvaggio di almeno cinque vitigni, è arrivata oggi a 2-3 di essi (il terzo, come si sa, può essere il Cabernet Franc, e un quarto possibile, il Petit Verdot, quando è presente lo è in piccolissima percentuale), quelli che, sintetizzando, rispondevano meglio alla maggiore completezza esprimibile di quel tipo di vino. Secondo una particolare ottica organolettica, però: perché, durante quella degustazione, ho capito una volta di più anche l’uso californiano, e del Nuovo Mondo in generale, che vede una sola di queste uve, in genere il Cabernet Sauvignon, come monologhista nell’atto unico del vino. (Ho detto ‘uso’: tra un po’ di anni verrà definito ‘tradizione’.) Anche qua c’è logica, c’è coerenza: mi è stato immediato, quasi sin troppo facile, vedersi riflettere, nel confronto fra questi tre vini, il confronto fra due diverse ottiche del vino stesso e persino del mondo: una ricca di sfumature, di riflessività, di razionalità ma anche di calore umano, l’altra ricca di espressività, di forza, di visionarietà più netta, più scolpita e meno pittorica. Mi sono chiesto da che parte stavo, e, pur aborrendo questa mia stessa domanda e apprezzando aspetti di ambedue le ottiche, il mio bicchiere di taglio bordolese vuoto davanti ai miei occhi alla fine della degustazione non mi ha lasciato dubbi.
La risposta al quesito posto all’esordio di questo scritto dipende, dunque, dall’ottica nella quale ci poniamo, nella quale, consciamente o inconsciamente, stiamo. Credo si possa riassumere così: il vino monovitigno, ove il vitigno, naturalmente, sia dotato di una certa personalità, risulta sempre più netto, più emozionale rispetto al vino da uvaggio, che spesso risulta più completo ed equilibrato. Ciò nei casi, ovviamente, in cui si possa fare un reale confronto tra le due possibilità, ossia nei casi in cui un vitigno dalla forte personalità venga, secondo alcune tradizioni viticole, vinificato assieme ad altre uve apparentemente o realmente solo comprimarie.
Esistono poi vitigni che, vuoi per la loro completezza-finezza (esempi: Pinot nero, Nebbiolo, Merlot), vuoi per la loro personalità inequivocabile e non bisognosa di completamenti (esempi, le uve aromatiche: Moscato, Malvasia, Traminer, Riesling, per certi versi anche il Sauvignon), si esprimono bene, nel vino, da soli, e non dal punto di vista di una sola delle due particolari ottiche prima descritte, ma per ambedue contemporaneamente. I vini provenienti dai vitigni della prima categoria possiedono anche da soli una personalità matura e completa, se trattati dal produttore con metodologie di vinificazione e di affinamento non troppo opprimenti, che rispettino la fragranza, la finezza e l’equilibrio che già all’inizio del loro sviluppo questi vini naturalmente hanno. I vini provenienti dai vitigni della seconda categoria vedono la loro ragione di esistere e di trasmettere un’ondata di piacevolezza a chi li beve nella loro ricchezza aromatica: qua è la natura a parlare, e per il produttore è importante lasciarla fare senza sovrapporre ad essa lunghi e ‘legnosi’ affinamenti, ma curando solo che l’impatto gustativo, per pienezza ed equilibrio, non deluda le spesso entusiasmanti premesse olfattive. Occorre sempre, insomma, ascoltare il vitigno, quel particolare vitigno per com’è in generale e per come si esprime in quel particolare microambiente, senza alcun preconcetto e anche senza superficialità.
Il filo di queste riflessioni mi porta a pensare a casa, cioè al nostro territorio piacentino, ai nostri vitigni, e a pensare subito ai più semplici tra essi, o così almeno in genere definiti: i vitigni che, insieme o da soli, danno i vini bianchi frizzanti delle nostre colline. Come sappiamo, per tradizione questi vini, nel secolo appena terminato chiamati Monterosso, Trebbianino o Valnure, nascevano tradizionalmente da un uvaggio, anche molto ampio, che poi si è andato attestando principalmente attorno a due uve principali, la Malvasia di Candia aromatica e l’Ortrugo, con presenza anche significativa (più per la percentuale di utilizzo che per l’influenza organolettica) di Trebbiano e, in alcune zone, incursioni di Moscato. Più recentemente, l’utilizzo dell’uvaggio è stato spesso abbandonato a favore del monovitigno, specialmente Ortrugo e Malvasia. I motivi credo siano stati diversi: l’eccessiva frammentazione delle denominazioni dei frizzanti da uvaggio (tre denominazioni diverse in un territorio della dimensione dei Colli Piacentini sono davvero troppe); la produzione per ceppo troppo elevata, specie nel caso della Malvasia, e una vinificazione non sempre corretta, col risultato di avere vini da un lato dominati da un’aroma invadente e pesante di Malvasia poco matura e poco fine e dall’altro sin da subito minacciati da un’ossidazione precoce; la produzione di alcuni bianchi da monovitigno interessanti, specie da uva Ortrugo.


Però, come dicevo prima, niente dev’essere scontato e occorre ascoltare i vitigni, sentire bene ciò che dicono: se i loro discorsi non ci soddisfano molto, ci sembrano infarciti di parole poco fini, pieni di concetti antiquati e vuoti nei loro contenuti, forse è perché l’uomo non li coltiva in modo da far risaltare le potenzialità dell’uva, e ne vinifica il vino con poca cura e passione. Penso che il tesoro-uva bianco a Piacenza si chiami Malvasia di Candia Aromatica, una delle uve bianche autoctone italiane più ricche e personali, che nelle versioni ferma secca e passita ha dato e sta già dando grandi risultati, ma le cui potenzialità vanno esaltate anche per i vini frizzanti. Specie in uvaggio, per l’appunto, perché se una Malvasia proveniente da uva con un carico per ceppo molto basso e raccolta a maturità piena o all’inizio della surmaturazione, può manifestare con grande facilità equilibrio ed eleganza, viceversa una Malvasia con un carico produttivo medio e raccolta abbastanza matura, ma anche ancora ricca di freschezza aromatica e di acidità come dev’essere un uva atta a dare vini frizzanti, se vinificata da sola difficilmente esprime quell’equilibrio e quell’eleganza di cui sopra; e soprattutto il suo aroma, come quello di tutti i frutti non completamente maturi, può essere un po’ eccessivo, invadente. Ecco allora che la tradizione dell’uvaggio qui acquisisce un senso organolettico, preciso e pure attuale: specie grazie all’intervento di quell’uva dall’aroma non molto intenso e personale seppure abbastanza sviluppato e dalla buona finezza, anche gustativa, che è l’Ortrugo; l’’altra uva’, appunto, come veniva definita nel passato ad indicare, probabilmente, un’uva ‘altra’, diversa dalla Malvasia, da aggiungere a questa in taglio. Credo che, lasciando da parte la fretta, l’attenzione ai risultati economici più immediati, la superficialità in generale, si possa risviluppare il discorso dell’uvaggio bianco sulle nostre colline. Partendo da ciò che la tradizione ci ha lasciato (concentrandosi magari sull’unione di due sole uve, la Malvasia e l’Ortrugo), ma con gli obiettivi più attuali possibili: l’alternativa al Prosecco credo sia qui, in un vino da uvaggio che abbia tutta la potenza aromatica della Malvasia, il calore della nostra terra e del nostro clima, ma anche una finezza ‘prosecchiana’, una ricchezza e una eleganza aromatica che solo una vinificazione moderna, e soprattutto una cura della fermentazione e della rifermentazione mediante le conoscenze e i mezzi più attuali, possono dare.


Dare un’identità (un nome, un’immagine comune) a un vino di questo tipo, su cui si concentrino, freschi e rinnovati, gli sforzi e l’entusiasmo di tanti produttori, credo non sia facile, ma è sicuramente possibile. Senza fretta, ma anche senza troppi dubbi: l’ascolto dei vitigni induce riflessione, ma anche voglia di essere degni dei tesori che la natura ci dona.
A Piacenza l’uvaggio principe è quello che dà il Gutturnio, e in questo caso, per fortuna, una tradizione che aveva, credo, un senso non è stata abbandonata; anzi, è stata rafforzata e si sta sempre più migliorando, anche se forse a volte un po’ lentamente, vista la velocità con cui tutto oggi, anche nel mondo del vino, procede e si trasforma. L’uvaggio Barbera-Bonarda credo sia ben armonizzato con quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio e del carattere delle persone che lo abitano. Forse mi sbaglio, ma mi risulta facile fare un parallelo tra una Barbera in purezza, col suo carattere spiccato e la sua leggera ruvidezza (ecco l’emozionalità di cui sopra) e una parte del territorio piemontese e del carattere della gente che lo popola, così come tra la maggior discrezione, armonia e serenità che caratterizzano l’accompagnamento della Barbera con la Bonarda e la serenità del paesaggio collinare piacentino e la tranquillità e la misura dei suoi abitanti. Ottima cosa insistere su questo matrimonio di vitigni, cercando però, è mia opinione, di armonizzarlo sempre più con l’essenza della nostra terra, sicuri degli aspetti positivi della propria identità di persone e della natura che ci circonda; senza seguire modelli diversi, più austeri e difficili, che meglio si armonizzano, appunto, con le realtà in cui sono nati. Insomma, io guardo con affetto a un Gutturnio frizzante che sia frutto pieno, lindo e vivacemente ma anche morbidamente brioso; e sogno un Gutturnio grande vino fermo, concentrato, profondo, caldo come spesso è il nostro clima estivo, ma anche immediato, complesso e non complicato, sereno come il paesaggio dei colli che lo producono.
Contemporaneamente, spero che sui nostri colli nascano sempre più ottimi esemplari di Bonarda in purezza, vitigno dalla ricchezza e dalla completezza forse ancora solo in parte esplorate.
( Fonte www.vinipiacentini.net )
Giudice degustatore ai Concorsi Enologici Mondiali più prestigiosi tra i quali:
» Il Concours Mondial de Bruxelles che ad oggi ha raggiunto un numero di campioni esaminati di circa n. 9.080, dove partecipo da 13 edizioni ( da 9 in qualità di Presidente );
>>Commissario al Berliner Wine Trophy di Berlino
>>Presidente di Giuria al Concorso Excellence Awards di Bucarest
>>Giudice accreditato al Shanghai International Wine Challenge
ed ai maggiori concorsi italiani.